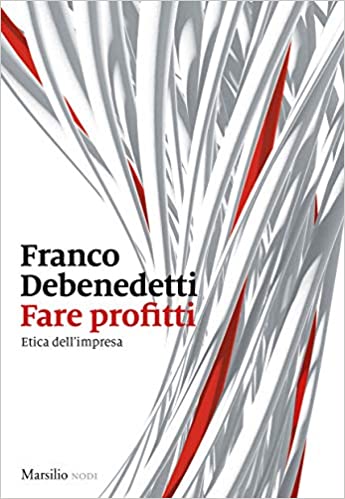La nascita della “costituzione più bella del mondo” fu accompagnata dal celebre ordine del giorno Perassi: la seconda Commissione, recita il testo presentato il 4 settembre 1946, «ritenuto che né il tipo del governo presidenziale, né quello del governo direttoriale risponderebbero alle condizioni della società italiana, si pronuncia per l’adozione del sistema parlamentare da disciplinarsi, tuttavia, con dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di Governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo». La storia politica e le vicende economiche dimostrano quanto perspicace fosse la preoccupazione di Perassi per una razionalizzazione della forma di governo parlamentare. Un dato per tutti: 68 governi nei 76 anni d vita della Repubblica, con una media di 13 mesi e mezzo ciascuno. «Tuttavia», per ricordare Perassi, di mettere mano alla forma di governo, per rendere gli esecutivi più stabili, se ne parla, come noto, da quasi quaranta anni (e da tre commissioni bicamerali e due referendum).
leggi il resto ›
Archivio per il Tag »La Stampa«
![]()
Intervista di Ludovico Poletto
Il dolore dell’amico: “Era capace di partecipare al dolore di tutti, si sentiva in colpa per la ricchezza e voleva dividerla con chi gli era vicino”
«Nel giro di un anno ho vissuto due dolori. Prima la morte di mia moglie, Barbara, e adesso quella del mio amico Gianni Vattimo. Li ho visti entrambi sul letto di morte: avevano posizioni identiche. Ed è una sofferenza ed una commozione fortissima quella che adesso mi assale».
leggi il resto ›
![]()
Caro Direttore,
se la foto di Mussolini è appesa al muro nella galleria di quelle di chi ha ricoperto la carica di ministro o di presidente del Consiglio, senza alcuna differenza né tanto meno enfasi, non vedo ragione di levarla. Anzi a dire il vero, vedo qualche ragione per lasciarla.
leggi il resto ›

Signor Sindaco,
mercoledì sera alla recita di Norma il pubblico è stato informato per altoparlante che il Regio esporrà i colori della bandiera della pace, in conformità a quanto deciso da ANFOLS, Associazione delle Fondazioni Lirico Sinfoniche. L’informazione non è corretta: sul sito ANFOLS sta scritto che “hanno deciso che esporranno i colori della bandiera ucraina o della bandiera della pace”.
leggi il resto ›
![]()
Caro Direttore, se, come lei scrive nel suo editoriale del 28 novembre, il Governo Prodi nel 1997 vendette Telecom Italia per l’equivalente di 11,82 miliardi di euro, e oggi il fondo Kkr può comprarne il 100% per 10,8 miliardi, la prima cosa che se ne deduce è che, contrariamente a quanto si sente ripetere in questa come in altre occasioni, lo Stato è stato un buon venditore. Non c’è stata nessuna svendita: i privati hanno pagato, a caro prezzo, con beneficio dell’erario. E non solo. E’ passato quasi un quarto di secolo, e di cose ne sono successe. Allora, grazie alla liberalizzazione imposta dall’Europa, a scalfire il monopolio Telecom era comparsa Omnitel. Nessuno poteva immaginare che l’Italia sarebbe diventata un mercato estremamente concorrenziale, dove sono attivi una pluralità di operatori, con le tariffe tra le più basse in Europa, con un’autorità di regolazione e controllo, istituita per poter privatizzare, che si sarebbe dimostrata molto severa verso l’exmonopolista. Se quest’ultimo fosse rimasto un’impresa pubblica, è improbabile vi sarebbe stato il medesimo zelo.
leggi il resto ›

La controversa vicenda del filosofo e del suo assistente, accusato dalla Procura cli “circonvenzione d’incapace”
«Ogni uomo trova, nella sua vita, una donna che lo vuole salvare: a volte ci riesce». La frase, incorniciata, stava in bella vista nell’ufficio di Libero Gualtieri, repubblicano, romagnolo, scapolo che avevamo eletto capo di «Sinistra Democratica», il gruppo parlamentare del Senato che avevo contribuito a costituire nella XII Legislatura. La frase mi attraversò veloce la mente quando, nell’autunno del 2018, sentii al telefono M., una delle amiche storiche di Gianni Vattimo, che, con voce concitata, mi chiedeva che cosa stesse succedendo da lui, dove a suo dire, regnava «un’atmosfera plumbea»: «Sempre quel Simone tra i piedi!» fu la sua replica alla mia richiesta di chiarimenti. Anch’io, quando invitavo Gianni a pranzo al ristorante, avrei preferito che a chiacchierare fossimo solo noi due, amici da poco meno di mezzo secolo. Ma Gianni non se la sentiva di uscire senza il braccio di Simone; senza l’aiuto di questo ragazzo di origine brasiliana, chi avrebbe risposto alle email, pagato le fatture, rimpiazzato le badanti, cercato i libri nei piani alti della libreria, affittato una casa dove rifugiarsi dall’afa estiva?
leggi il resto ›