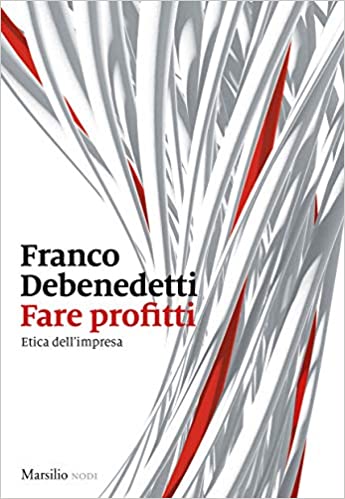![]()
La Volkswagen aveva avuto un pessimo 1992, perdeva circa 400 marchi per ogni Golf venduta. Per cercare di ribaltare la situazione, era stato nominato presidente il capo della divisione Audi, Ferdinand Piech. Fu lui a reclutare, quale responsabile dei metodi di produzione e degli acquisti, un ingegnere basco un po’ eccentrico mosso da feroce determinazione, José Ignazio López, all’epoca capo degli acquisti della General Motors.
Cominciava così un «giallo industriale». tanto appassionante quanto inquietante, tutt’altro che concluso, che può farci riflettere, anche in Italia, sulle finalità e i metodi di gestione di un’impresa.
leggi il resto ›
![]()
Caro Sindaco, oggi, con l’ingresso in Sala Rossa, inizia di fatto il tuo mandato. I momenti di inizio non sono solo ritualità simboliche, hanno una loro funzionalità precisa: sono i momenti in cui si confermano le intese, in cui si rinnovano le promesse; sono soprattutto i momenti di massima concentrazione delle volontà. Le accuse che già a lume di buon senso paiono infondate, l’uso ostruzionistico della procedura per riprodurre vecchi sistemi che gli elettori sapranno giudicare e ricordare, hanno già privato Torino di non pochi giorni di lavoro: con gli auguri che oggi facciamo al primo sindaco che abbiamo eletto direttamente vorremmo anche recuperare, a te e alla città, i valori di entusiasmo e di determinazione che devono accompagnare l’inizio di ogni impresa.
leggi il resto ›
![]()
L’hanno chiamata «Restore hope»; ma quale speranza, e di chi? La speranza di Bush di lasciare la Casa Bianca a testa alta, di rinverdire, mandando i marines in Somalia, gli entusiasmi che durante la guerra del Golfo gli avevano valso consensi quasi plebiscitari?
O la speranza di Clinton di dimostrare di saper prendere decisioni, e di riaffermare il ruolo, forte e giusto, dell’America, in tutti i teatri del mondo?
leggi il resto ›
![]()
Lo storico accordo sul costo del lavoro segna la fine dei meccanismi automatici di adeguamento dei salari, e la modifica dei rigidi rituali di contrattazione: ma diventa, inevitabilmente, l’inizio della riforma dello Stato sociale. La concertazione salariale non può non legarsi al rapporto prestazioni-prezzi di quanto è fuori dalla busta paga, a incominciare da previdenza, sanità e fisco; e quindi logicamente estendersi all’istruzione e ai trasporti; per poi rimandare al decentramento amministrativo e impositivo. Un nesso, logico ed economico, lega la riforma alla busta paga a quella dello Stato sociale e questa alla’ riforma della pubblica amministrazione: problema disperarne.
Eppure val forse la pena dare uno sguardo indietro, E` finora riuscita, e pareva impensabile, una svalutazione (in parte competitiva) senza inflazione. Pur con le sue vaghezze sul piano implementativo, il processo di privatizzazione dovrebbe essere al riparo da pregiudiziali ideologiche e da escamotages trasformistici. Con tutti i suoi difetti, la legge elettorale consentirà una maggiore rispondenza tra società civile e rappresentanza politica. La lezione di Tangentopoli dovrebbe, almeno per un po’, introdurre maggiore correttezza nei rapporti con la pubblica amministrazione. La debolezza del Parlamento prefigura di fatto i poteri di un esecutivo direttamente eletto. Perché non pensare che si riesca ad attaccare anche il problema della burocrazia amministrativa?
La crescita dello Stato sociale si è realizzala caricando l’amministrazione di sempre maggiori compiti. Dottrina sociale cristiana e ideologie collettivistiche si sono saldate in pratiche di intervento diretto dello Stato nell’economia. E le amministrazioni hanno perso per strada il significato anche etimologico de termine governare, dal latino gubernum, timone: si sono abituate più a faticare sui remi che a usare la capacità di guidare la rotta. Il tipico modo di agire è secondo catene aperte: si stabiliscono regole e si dispone che ad esse si obbedisca; il modello ideale è l’uguaglianza, gli stessi servizi a tutti. Ma al differenziarsi della società, all’aumento dei compiti richiesti alle amministrazioni, questo modello si è inceppato: oggi, in tutto il mondo, la gente vuole più servizi con le stesse risorse.
Sul problema della riforma della burocrazia si sono spese invano intelligenze illustri e competenze predare. Non si tratta sole, di riformare istituti specifici: e prima di tutto un problema di metodo. Bisogna introdurre nell’amministrazione spirito imprenditoriale, spostare cioè risorse economiche da un’area di bassa ad una di maggiore produttività e resa.
Non si vorrebbe generare un equivoco: le amministrazioni non sono imprese. Non per le motivazioni (la misura del successo per gli amministratori è essere rieletti, per gli imprenditori il profitto), né per i modi di operare (i governi sono democratici ed aperti, le imprese devono prendere decisioni rapide in condizioni di incertezza), né per gli obiettivi (il bene per tutti contro i profitti per alcuni). Privatizzare è una delle soluzioni, non è la soluzione: si possono privatizzare alcune funzioni, ma ci sono compiti (introdurre equità, evitare discriminazioni e sfruttamenti, promuovere la coesione sociale) che solo il pubblico può garantire.
Governare significa fare lavorare la burocrazia pubblica e il settore privato, insieme al terzo settore, quello del volontariato o delle attività non-per-profitto: settore questo che in tutte le società complesse tende ad assumere un ruolo sempre più importante, il solo che sappia trattare problemi in cui è necessaria attenzione individuale, capacità di raggiungere strati sociali diversi, introducendo elementi di fiducia, di coesione, di impegno personale.
Per introdurre spirito imprenditoriale nell’amministrazione non basterà (anche se non par
cosa da poco) mutuare le metodologie che le imprese dinamicamente sviluppano, autonomia decisionale e motivazione delle persone, qualità e misurazione dei risultati; introdurre criteri di decentramento, di concorrenzialità (magari tra le stesse funzioni svolte e dal pubblico e dal
privato), di attenzione alle necessità dei clienti, di orientamento agli obiettivi più che alle norme. Diventare imprenditoriali significa utilizzare in modo innovativo gli strumenti di autoregolazione e di incentivo del mercato. Non è la vecchia ricetta «meno Stato più mercato»; le amministrazioni possono modificare i mercati, stabilendo regole, indirizzando la domanda, agendo da catalizzatori, introducendo l’arte di saper misurare; non solo l’efficienza di un servizio, ma l’efficacia del suo risultato.
Il problema della riforma amministrativa scoraggia per vastità e complessità. E allora una proposta: perché non incominciare dai Comuni? Certo, il grosso dei problemi riguarda l’amministrazione centrale: ma la riforma è nel metodo. Il dilemma meno tasse e meno servizi o più tasse e più servizi, non si risolve (solo) chiedendo maggiore efficienza, o selezionando secondo criteri economici o egualitari o di popolarità, ma reinventando il modo di governare. La dimensione delle nostre città, l’autorità che la nuova legge elettorale conferisce ai sindaci, la partecipazione civile con cui sono stati eletti, potrebbero fare dei Comuni il luogo da cui iniziare a por mano alla più difficile di tutte le riforme.
![]()
Lo spettro si aggira per l’Europa: la crescente disoccupazione. 18 milioni di persone, il 10 per cento della popolazione attiva, sono esclusi dal diritto al lavoro: il problema è stato al centro del vertice della Comunità Europea a Copenaghen.
Il fenomeno presenta in Europa caratteristiche particolarmente inquietanti, anche perché, mentre in Usa la disoccupazione diminuisce alla ripresa del ciclo economico, in Europa essa cresce costantemente: dieci anni fa era del 2 per cento, nel 1979 era del 5,4 per cento, nel 1990 era dell’8,3 per cento. E’ un fenomeno chi cui anche le cause restano sfuggenti.
Certo gli sviluppi della tecnologia e dell’automazione hanno ridotto il numero dei posti di lavoro: ma l’Europa è cresciuta proprio grazie alla introduzione di nuove tecnologie. Se questa fosse la causa, la disoccupazione dilagherebbe in Europa da un secolo.
leggi il resto ›
![]()
Le astensioni potrebbero, domenica prossima, essere numerose: se così fosse, si tratterebbe di un fatto in controtendenza rispetto al processo in atto.
Il voto referendario del 18 aprile è stato notevole non solo per la percentuale del sì (83 per cento) ma anche per l’altissima Percentuale dei votanti (77 per cento). Secondo l’analisi che ne fanno Corbetta e Parisi (Il Mulino, maggio ’93) questo dato, depurato dell’astensionismo aggiuntivo tipico dei referendum, equivarrebbe ad un tasso di votanti, proiettato su elezioni politiche, superiore al 90 per cento.
leggi il resto ›