→ aprile 11, 2016
Intervista di Stefano Carli a Tommaso Pompei
“La scommessa di dotare il paese di una infrastruttura di rete a banda ultra larga, in fibra ottica fino alle case degli utenti, e anche, ovviamente, fino ad ogni singola piccola impresa e laboratorio artigiano è partita. Ed Enel Open Fiber ha numeri, asset competenze e risorse per coprire l’intero paese in tempi brevi. Perché questa scommessa si vince solo nel momento in cui il 100% del paese sarà coperto: le 224 città che copriremo entro tre anni valgono il 48% del pil italiano. E le aree a fallimento di mercato, i cluster C e D, per cui parteciperà alle gare, ne rappresentano un altro 24%. Vuol dire che in tre anni doteremo di connessioni in fibra le imprese che producono i tre quarti della nostra ricchezza”.
Tommaso Pompei, ad di Open Fiber, ancora per un po’ di mesi 100% Enel, è appena tornato dalla conferenza stampa in cui il premier Matteo Renzi ha presentato la sponsorizzazione ufficiale del governo del piano Enel con lo slogan “Banda ultralarga ovunque”, ribadendo gli obiettivi del 100% di popolazione italiana connessa a 30 mega e il 50% almeno a 100 mega entro il 2020. Open Fiber svilupperà quindi la sua rete nelle aree di mercato, e nelle aree a fallimento di mercato, le cosiddette aree bianche dei cluster C e D. Nelle prime attiverà negli anni un investimento complessivo stimato in 2,5 miliardi di euro. Nelle seconde parteciperà alle gare che assegneranno la realizzazione
e la gestione, attingendo a fondi pubblici per 4,9 miliardi. Ma per questi bisognerà attendere che le gare stesse siano bandite e Renzi ha promesso che il quadro completo, con le regole e i primi bandi verranno presentati il prossimo 29 aprile. I tempi sembra si stiano accorciando. E sarebbe il momento visti i ritardi accumulati fin qui. Poi si dovrà attendere che le reti siano via via completate.
Ci vorrà molto?
“Abbiamo un progetto pilota a Perugia dove entro maggio allacceremo i primi 50 utenti – spiega Pompei -. I lavori sull’intera città partiranno a settembre, assieme a quelli delle altre 4 città del primo blocco che abbiamo annunciato giovedì scorso: Cagliari, Bari, Catania e Venezia. Poi progressivamente le altre 219 città che ci siamo impegnati a coprire entro tre anni. Nei nostri piani in una città da 200 mila abitanti contiamo di poter passare in 8 mesi dall’apertura del cantiere all’offerta della fibra agli operatori. E voglio sottolineare che noi consideriamo “coperta” una città non già con poche connessioni, come spesso oggi si usa fare, ma quandoavremo effettivamente collegato l’80% degli utenti”.
Tempi ravvicinati: su cosa basate lacertezza di riuscirci?
“Sul fatto che Enel ci fornisce tre pilastri strategici. Il primo è la capillarità della sua infrastruttura elettrica, con un milione di punti di distribuzione all’interno dei quali potremo articolare la nuova rete. Il secondo è rappresentato dalle sinergie attivabili nella gestione e manutenzione delle due infrastrutture. Il terzo è la possibilità di arrivare fino ai contatori elettrici delle utenze. Oggi le linee telefoniche sono circa 20 milioni. Le utenze elettriche il doppio: 33 milioni di contatori Enel più altri 6 milioni delle altre utility dell’energia. Colgo l’occasione per ribadire però che le sinergie sono solo di carattere organizzativo e operativo e derivano unicamente dalla concomitanza delle due attività. La posa della fibra da parte di Enel Open Fiber non sarà in alcun modo finanziata dalla remunerazione stabilita dall’Autorità per la sostituzione dei contatori elettronici, svolta da Enel Distribuzione. Si tratta di due attività totalmente separate, senza alcun rischio di sussidi incrociati, come recentemente chiarito nettamente dall’Autorità per l’Energia”.
Avete già contattato le altre utility per invitarle a partecipare all’iniziativa?
“Non ancora ufficialmente, siamo nella fase di avvio del progetto ed è stato un lavoro duro, ma sanno che la porta è aperta. Tornando ai tempi, abbiamo analizzato il territorio, abbiamo fatto, per così dire, dei carotaggi in 38 città di diversa tipologia, geografica, ambientale, urbanistica, economica e ora abbiamo un quadro completo di quello che ci troveremo ad affrontare”.
Avete quindi un quadro chiaro di tutte le possibili sinergie con la rete elettrica. Quanta parte ne potrete utilizzare?
“In estrema sintesi possiamo dire che non utilizzeremo certo tutto il potenziale dei 450 mila armadi elettrici, pensiamo ce ne serviranno più o meno una metà. Questo anche grazie al fatto che la fibra ha una portata maggiore in termini di distanza rispetto al rame. Se sulla rete in rame il segnale perde di qualità oltre i due chilometri di distanza dell’utente finale dalla centrale, con la fibra arriviamo a 40 chilometri. Questo semplifica molto il lavoro e le opere nella cosiddetta rete secondaria, quella dell’ultimo miglio fino ai palazzi. Poi con la rete “verticale” porteremo la fibra dalla base del palazzo alle case degli utenti. Nella rete primaria collegheremo in fibra tutti gli armadi che utilizzeremo e collegheremo questi alla rete primaria di Telecom Italia, quella dove sono le loro centrali e quelle dove sono attestati i concorrenti, da Vodafone a Wind, a Fastweb”.
Poserete molta fibra. Quanti scavi ex novo dovrete fare?
“Diciamo che dove abbiamo i pali della rete aerea l’utilizzabilità dell’infrastruttura elettrica è al 100%. Nel caso delle linee interrate, siamo invece al 20%, come media generale. Dato tutto questo, l’impatto della rete elettrica sulla realizzazione della rete in fibra, in termini di minori costi delle opere civili, si concretizza in uno “sconto” del 30% circa rispetto ai costi medi. E le opere civili sono gran parte dei 2,5 miliardi di investimento programmato per le 224 città. Più o meno tutto quello che resta dopo aver speso circa 350 milioni in hardware, e altri 200 in software, gli impianti di rete. Sulla velocità di realizzazione pesa poi, in positivo, anche il fatto che completata la rete questa sarà subito in grado di produrre ricavi grazie all’accordo con Wind e Vodafone. Che è pronto: le firme ufficiali arriveranno in pochi giorni ma abbiamo già messo a punto tutti i dettagli che contano: tempi di consegna, standard di servizio, modalità di gestione e anche i prezzi. Che però ora non posso rivelare”.
Seguiranno accordi anche con Telecom, Fastweb e altri?
“Sì. O meglio, noi siamo aperti. E abbiamo contatti con tutti gli operatori tlc, inclusa Telecom, almeno fino al recente cambio di management. Con Fastweb stiamo parlando non solo di accordi commerciali ma anche di integrazione con la loro rete: si potrebbe arrivare ad utilizzarne segmenti più o meno estesi. E poi sappiamo che ci sono altri operatori interessati, da Tiscali agli operatori che oggi offrono accessi a banda larga fissa ma con connessione radio, come nel caso del wi-max o delle hyperlan: tutti assieme i “piccoli” valgono l’11% degli utenti” .
Con Telecom sarete concorrenti, ma cosa succederà di fatto? Oggi le regole impongono di non scavare due volte nella stessa strada. Quindi dovrebbe accadere che voi possiate chiedere di passare nei cavidotti di Telecom e viceversa, Telecom nei vostri. Un po’ come avviene nell’accordo tra la stessa Telecom e Fastweb.
“Chiariamo bene: non siamo in concorrenza né con Telecom, né con alcun altro operatore, anzi proponiamo loro una infrastruttura che tutti possono utilizzare. Comunque le modalità sul mutuo utilizzo dei cavidotti sono regolate, anche se non credo sia una questione che si porrà subito nei primi mesi” .
Si riprende a parlare di scorporo delle rete Telecom. Come potrebbe inserirsi in questo scenario?
“E’ un vecchio tema, sul quale non abbiamo alcuna voce in capitolo, ma che ha visto sinora contrario il management ed il board di Telecom stessa. Piuttosto va posto ora un tema che dovrà prima o poi trovare una nuova sistemazione: tutto l’impianto regolamentare del settore è tagliato su misura su un modello di operatore telefonico integrato verticalmente, possiede le reti e vende servizi agli utenti. Noi non venderemo mai connessione agli utenti finali”.
Capitolo soci: l’ad di Enel Starace ha parlato dell’ingresso di nuovi partner in Open Fiber già dopo l’estate.
“Presto per fare oggi dei nomi, posso solo dire che c’è una nutrita lista di candidati che si stanno facendo avanti”.
Compresi F2i e il Fondo Strategico della Cdp, ossia gli attuali proprietari di Metroweb?
“Si vedrà”.
Ma si può dire che in fondo Open Fiber è una Metroweb in grande?
“In gran parte si: ma puntiamo ad andare anche oltre. Noi non ci limiteremo a vendere solo fibra spenta, ma vorremmo aggiungere dei servizi, dell’intelligenza di rete. Andare dunque oltre la vendita del puro ‘tubo’. Intanto offriremo alle telco che compreranno la nostra fibra anche i servizi di hosting, ospiteremo i loro apparati di rete nelle nostre centrali. E poi stiamo pensando anche alla vendita di ‘fibra accesa’: porzioni virtuali di fibra. Anche con possibilità di ampiezza di banda differente e quindi diversificata per prezzo”.
Una banda ultralarga on demand, come il cloud?
“In sostanza sì: è un modo per abbattere ancora di più le barriere di ingresso a nuovi operatori e a nuovi servizi. E con il boom annunciato dell’internet delle cose e della sensoristica ci sarà bisogno proprio di questo”.
→ marzo 9, 2016
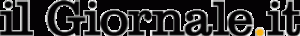
articolo collegato di Cinzia Meoni
Le utility non sempre sono la risposta giusta allo sviluppo della rete nelle tlc. L’Enel punta, come noto, a posare e gestire una rete in fibra ottica. Ma non tutto è così semplice come sembra. Lo dimostra il caso di Dong Energy (Danish oil and natural gas). Il colosso dell’energia danese controllato dal governo di Copenaghen, proprio 12 anni fa aveva provato a percorrere la strada della sinergia tra i due business, quello delle utility e quello delle rete tlc, forte della prospettiva dei numerosi vantaggi teorici. Il modello di business, quello infrastrutturale, è in effetti simile, quanto meno in apparenza. Le reti richiedono sempre forti investimenti, garantiscono ritorni prevedibili, generano consistente cassa e vantano una diffusa capillarità, presupposto per possibili vendite trasversali di servizi.Su queste basi, nel 2004, Dong Enegy ha deciso di sfruttare la propria capillare infrastruttura di rete per entrare nel mercato dell’Ftth (ovvero fiber to the home). Tempo tuttavia cinque anni e l’esperimento è stato ufficialmente dichiarato chiuso, con la vendita delle attività di rete di Dong Energy a Tdc. Un’uscita mesta, attraverso cui la multi-utility ha recuperato meno della metà degli investimenti effettuati per posare 5,5mila km di rete e raggiungere 220mila immobili (ma solo 15mila famiglie). Nonostante le attraenti premesse, i vantaggi teorici di cui Dong Energy avrebbe dovuto beneficiare, erano rimasti solo sulla carta, dimostrando che il business tlc non è solo questione di fibra. Proprio mentre in Italia tornano di attualità simile tematiche, il caso Dong Energy, come evidenziato da uno studio di Diffraction Analysis – società di ricerche di business – insegna che saper trasportare energia non significa, necessariamente, saper far utili attraverso le autostrade delle telecomunicazioni. A Dong è mancata, secondo gli esperti, la creazione di un’economia di scala che permettesse al gruppo di ottenere efficienze e riconoscibilità del brand, anche attraverso accordi con altri operatori. Non solo. Uno dei grandi errori è stato quello di non prevedere né una chiara politica di prezzi comprendente oltre all’accesso alla rete anche i servizi, né un’allettante proposta di contenuti premium tali da spingere i danese a sottoscrivere contratti.
→ febbraio 15, 2016

To proponents of a cash-free society, the survival of the $100 bill is at best an anachronism, at worst a gift to organised crime. Peter Sands, the former chief executive of UK-based Standard Chartered bank, last week called for the note to be consigned to history, alongside other high-value banknotes beloved of drug barons and kleptocrats. They play little part in the legitimate economy, he argues, but a crucial role in the underground economy.
leggi il resto ›
→ gennaio 31, 2016

articolo collegato di Sergio Bocconi
Si profila un nuovo confronto Italia-Europa. Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, intervenendo sabato al Forex di Torino, sollecita una revisione dei meccanismi europei di risoluzione delle crisi bancarie, e in particolare del bail in, entrato in vigore in gennaio. La Commissione Ue fa però subito sapere che «non ci sono piani per cambiare la direttiva, adottata nel 2014 con il consenso di una stragrande maggioranza al Parlamento europeo e con l’accordo unanime degli stati membri. Da un anno e mezzo si sa che il bail in dei creditori avrebbe protetto i contribuenti».
Al Forex Visco ha poi spiegato l’intervento sui quattro istituti in dissesto; ha approvato l’intesa con la Commissione Ue sulla garanzia pubblica per liberare i bilanci del settore dalle sofferenze e ha rinnovato l’appello a una maggiore diffusione della cultura finanziaria. Il Governatore ha quindi dedicato spazio alla congiuntura: in Italia la ripresa procede a ritmi moderati, come nell’area euro, sostenuta dalla domanda interna. Resta l’indicazione che nel 2016 e nel 2017 il prodotto possa crescere dell’1,5%. Sono in aumento i prestiti al settore privato e in particolare alle famiglie per i mutui. Dettagliata è stata la spiegazione relativa ai provvedimenti adottati nel novembre 2015 da governo e Bankitalia per risolvere le crisi di Banca Marche, Popolare Etruria, CariFerrara e CariChieti, che nel complesso detenevano l’1% dei depositi italiani. Visco spiega che, dopo lo stop europeo all’utilizzo del Fondo interbancario, assimilato ad aiuto di Stato, sono state applicate le regole introdotte con la direttiva europea sulle crisi bancarie. I costi sono stati sopportati, oltre che dagli azionisti e i detentori di obbligazioni subordinate, dal sistema bancario attraverso il Fondo di risoluzione. L’alternativa? La liquidazione coatta. Da gennaio è entrato invece in vigore il bail in, che prevede il coinvolgimento con perdite anche delle obbligazioni ordinarie e dei depositi sopra i 100 mila euro. Secondo Visco le nuove regole, maturate in sede europea dopo i massicci interventi pubblici per i salvataggi bancari (che non si sono verificati in Italia) hanno comportato un cambiamento «drastico e repentino». Secondo Bankitalia e ministero dell’Economia invece di un’applicazione immediata e retroattiva dei nuovi meccanismi sarebbe stato preferibile un periodo di transizione per consentire a banche e risparmiatori di adattare strumenti e percepire rischi finora remoti. Ecco dunque la richiesta di revisione, possibile entro giugno 2018, precisa Visco, grazie a una clausola. Ma la Commissione Ue ha frenato.
E sempre sulle crisi Bankitalia precisa di aver chiesto alla Etruria a fine 2013 misure correttive e un’aggregazione. Ma il board dell’istituto nel 2014 ha rifiutato l’unica offerta «autonomamente avanzata dalla Popolare di Vicenza» (quindi non sponsorizzata dalla Vigilanza). Infine il Governatore invita le banche a predisporre meccanismi volontari di intervento, aggiuntivi rispetto ai sistemi obbligatori di garanzia dei depositanti, per contenere i costi di una crisi per i risparmiatori. Così come l’accordo sulle sofferenze (il cui flusso si sta riducendo) deve essere accompagnato da una migliore capacità di intervento da parte degli istituti. «Sarà utile lo schema di garanzia concordato con la Commissione Ue per facilitarne lo smobilizzo. Il mercato potrà attivarsi. Ma nessun provvedimento può cancellare la massa di sofferenze del passato: vanno aggredite con determinazione». L’Italia, viene sottolineato, sta uscendo da un periodo più grave della depressione degli anni Trenta: la crisi ha messo a dura prova imprese, famiglie e banche. Gli istituti però oggi hanno un patrimonio «molto più elevato rispetto al passato» e il rafforzamento, a differenza di altri Paesi, «è stato conseguito senza pesare sulle finanze pubbliche». E anche la redditività comincia a migliorare.
→ gennaio 27, 2016

articolo collegato di Martin Sandbu
Arigged market price
Almost everything about Italy’s agreement with Brussels over the country’s so-called “bad bank” policy to rid Italian banks of its problem loans should set off alarm bells. It illustrates how halfhearted is Europe’s commitment to reform the way it does banking.
The agreement, as the Financial Times reports today, involves a scheme by which the Italian state will issue financial guarantees for packages of non-performing loans that are burdening the banks’ finances. The guarantees are supposed to help the banks sell off the loans to other types of investors such as hedge funds.
To be clear, getting bad loans off Italian banks’ backs is a good idea. At about €350bn or 17 per cent of the banking system’s total loan book (three times the European average, according to the European Banking Authority’s last transparency exercise), they constitute a large patch of rot on the banking system’s balance sheet. The uncertainty over the eventual size of the losses is bound to restrain both the banks’ willingness to issue loans and their ability to raise capital as and when that becomes necessary. That fact that Italian bank lending is growing again, which is very welcome news, is nevertheless no reason not to shift this uncertainty to investors willing to bear it and whose risk exposure does not damage the wider Italian economy.
It’s such a good idea, in fact, that it’s useful to ask why banks haven’t sold off these loans to foreign hedge funds already. The Italian government’s plan has been to issue guarantees on the bad loans to facilitate their sale. The sticking point with the European Commission has been how to price the guarantees so they don’t constitute a subsidy. The agreement supposedly ensures that the insurance against losses will be sold at the market price for similar loss insurance on equally risky products.
But if it’s the market price, why does the government need to be involved at all? There are plenty of investment banks in the world that will issue loss insurance at a price. And there is little reason to think that the Italian government’s risk assessment is more reliable than a third-party investor’s: on the contrary. The very notion that the government must provide the insurance because the market doesn’t should make us suspicious of the risk it attributes (or rather not) to the loans in question.
If banks are not already selling off loans to private investors, it’s because the price at which they are willing to sell is higher than the price buyers are willing to pay. The reason for that is most probably not that the banks know the loans are better than they look. Instead, it is that a price at which buyers would be interested would expose losses that the banks would rather be without — or pretend to be without.
The only way a state guarantee can get around this problem is by making the bad loans look more attractive to investors, and thereby raise the price they would consider paying to a level that flatters the selling banks. But don’t let Rome and Brussels fool the rest of us into thinking that this is a market price: if the government needs to make it happen, it’s a price at which there is no market.
The alternative policy is, of course, to write down the value of the trouble loans to their real market value, which could be done, for example, by forcing banks to auction them off to the highest bidder with no state-sponsored insurance (banks could buy the insurance privately if they thought it would sufficiently raise the market price). That this has not happened simply illustrates that Rome remains unwilling to apply the spirit of the EU’s new bail-in rules, which requires bank shareholders and creditors to share in any losses. Yet again, a proper restructuring is too much to stomach for a national government.
As Free Lunch has complained during a previous public bout of Italian bank rescues, this unreconstructed attitude illustrates that European governments are still not comfortable with the banking reforms they signed up to in 2012. That is dispiriting but not surprising. That Brussels is willing to play along, however, is both.
Other readables
- An idea developed to address the job displacement due to trade and globalisation may well have a new lease of life in an era of job loss through automation: Lori Kletzler argues for wage insurance, which would compensate displaced workers for the lower salary in whatever job they managed to find.
- New research documents the long-term effect of migrating from a poor to a rich country by comparing winners and losers of New Zealand’s immigration lottery for citizens of Tonga.
- Harvard economist Gita Gopinath chills the optimism about India that many — including Free Lunch — had allowed themselves to feel. about India’s economy. Investment is falling, not just because reform promises have not been kept, but because of growing rot in the banking system. Seventeen per cent of Indian bank loans are in bad shape, and the cost of borrowing has soared.
→ gennaio 20, 2016

articolo collegato di Luigi Zingales
Mentre i titoli di Monte Paschi e Carige scendono a picco (rispettivamente -46,8% e -38,3% dall’inizio dell’anno) e il presidente della Consob si scaglia contro i presunti speculatori responsabili di ogni male, il ministro del Tesoro cerca disperatamente di accelerare i tempi per risolvere il problema delle sofferenze bancarie. Il peggior nemico degli investitori è l’incertezza.
L’incertezza sulle entità delle perdite delle banche crea più danno delle stesse perdite, paralizzando i mercati e bloccando la possibilità di prestiti. Per risolvere lo stesso problema nel settembre 2008 il Ministro del Tesoro degli Stati Uniti Paulson lanciò Tarp (Troubled Assets Relief Program), un programma governativo di 700 miliardi di dollari per comprare titoli tossici dalle banche, molto simile alla prima versione della “bad bank” proposta da Padoan. Allora a far crollare i titoli bancari negli Usa erano i famigerati titoli tossici subprime e non i prestiti, ma il problema che Paulson si trovò ad affrontare non era diverso da quello che oggi assilla il nostro Padoan. Come nel caso della crisi Usa, non si tratta di un problema di alcune banche, ma di un problema generale, che si manifesta prima laddove è più acuto, ma che rischia di coinvolgere l’intero sistema bancario. E non è solo un problema dei banchieri. Se le banche sono in crisi, non prestano e se non prestano è difficile che l’economia riparta.
Nonostante il sostegno da parte dell’establishment di entrambi i partiti, la prima versione di Tarp fu rigettata alla Camera dei Rappresentanti. Solo dopo molte trasformazioni il programma fu approvato. Ci sono dubbi su quanto l’intervento statale sia servito a rilanciare i prestiti all’economia, ma certamente ha contribuito a stabilizzare le banche, evitando una crisi ancora più profonda. Molto più difficile da calcolare sono le conseguenze politiche. L’ondata populista che sostiene la nomina di Trump e Cruz da un lato e di Sanders dall’altro si è formata proprio nell’opposizione popolare al salvataggio delle banche tramite Tarp. Che cosa possiamo imparare dall’esperienza americana?
Innanzitutto è importante capire che tanto in Tarp quanto nella nostra bad bank si mischiano due obiettivi: rilanciare l’economia e trasferire parte delle perdite derivanti da cattivi prestiti alla comunità. Il primo è un obiettivo meritorio, il secondo è una forma opportunistica di “rent seeking” da parte dei banchieri. Purtroppo non è facile raggiungere il primo obiettivo, senza contribuire in qualche modo al secondo. Ma è importante che l’aiuto alle banche sia un danno collaterale, che si vuole minimizzare, non l’obiettivo primario della manovra.
Affinché questo avvenga è necessario essere molto chiari sull’obiettivo immediato dell’intervento: ricapitalizzare le banche. Se questo è l’obiettivo – come lo fu per Tarp – , ci sono molti modi per conseguirlo. Strapagare per i loro crediti inesigibili non è il metodo migliore, non è neppure quello più economico. Ha il solo vantaggio di nascondere agli occhi degli elettori il trasferimento di soldi alle banche. Invece di favorirne l’approvazione, questo inganno suscitò negli elettori americani il sospetto che la manovra fosse unicamente mirata a trasferire soldi alle banche, di qui la reazione.
Il nuovo piano del Ministro Padoan di far acquistare le sofferenze a «prezzi di mercato» con una garanzia della Cassa Depositi e Prestiti rischia di avere gli stessi effetti. I prezzi di mercato per questi crediti non esistono, basta vedere Banca Etruria che ha venduto alcuni crediti incagliati al valore di bilancio (intorno al 40% del valore facciale) pochi giorni prima che la Banca d’Italia valutasse il resto dei suoi crediti incagliati al 17,5 per cento. Qual è il vero prezzo di mercato? Dipende dalla qualità dei crediti e dalla natura delle garanzie. Quindi non esiste un prezzo di mercato ma molti, troppi prezzi diversi per un acquisto dei crediti in massa. Proprio per queste difficoltà Paulson finì per abbandonare l’idea di acquistare i titoli tossici e preferì “costringere” le banche a fare degli aumenti di capitale sottoscritti dal Tesoro. Gli investimenti furono fatti in azioni privilegiate senza diritto di voto e con sufficienti restrizioni da spingere le banche sane a raccogliere più capitale sul mercato. Il meccanismo funzionò. Non solo il sistema bancario fu stabilizzato, ma il Tesoro americano finì perfino col guadagnare da questi investimenti.
Lo stesso dovrebbe fare il Tesoro italiano, magari attraverso la Cassa Depositi e Prestiti. Mettere le banche di fronte alla scelta: o raccogliete un altro XX per cento di capitale di rischio sul mercato o questo capitale di rischio necessario a stabilizzare la banche e a far ripartire i prestiti ve lo diamo noi Stato, ma ad alcune condizioni. Primo, divieto di pagare dividendi per almeno tre anni. Secondo, ricambio totale del management. Terzo, azione di responsabilità obbligatoria in tutti i casi in cui ci si sia evidenza di mala gestio o di prestiti in conflitto di interesse. Quarto, nuove regole per evitare che tali conflitti di interesse possano ripetersi in futuro.
Ovviamente ci verrà detto che è impossibile perché Bruxelles non permetterà mai un intervento di questo tipo. Ma se Bruxelles concede alla Cassa Depositi e Prestiti di offrire delle garanzie a prezzi molto dubbi, non si capisce come possa vietare alla stessa Cassa di effettuare questi investimenti in azioni. Obiezioni verranno anche da chi teme una nazionalizzazione del nostro sistema bancario. Il rischio è serio. Ma c’è solo una cosa peggiore di una nazionalizzazione delle banche: una socializzazione delle perdite, quando i profitti rimangono privati. È quello che accadrebbe con la bad bank progettata dal governo.
Con la versione italiana di Tarp prospettata qui sopra, invece, il Governo prenderebbe due piccioni con una fava. Da un lato, renderebbe più solido il sistema bancario, evitando molti dei rischi di cui si è molto parlato nei giorni scorsi. Dall’altro, promuoverebbe un miglioramento della governance bancaria, uno dei punti più oscuri della nostra economia.








