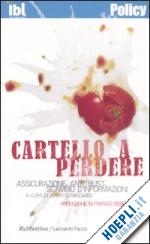
Cartello a perdere.
Assicurazioni, Antitrust e Scambio d’Informazioni
a cura di Alberto Mingardi
Prefazione di Franco Debenedetti
Rubbettino Editore, 2008
pp. 319
In un libro in cui si parte da sentenze antitrust in questioni riguardanti vari rami assicurativi, per discutere dei principi, teorici, ideologici e politici, su cui si basa l’attività antitrust stessa, e quindi sottoporne a critica i costrutti fondamentali, mercato rilevante, attività collusiva, quello stesso di concorrenza, giungendo infine a mettere in serio dubbio la possibilità di un antitrust che non sia distorcente del mercato; in un siffatto libro non può mancare una considerazione sulla situazione esistente fino a pochi anni fa in un Paese quale il nostro, in cui il 50% delle attività economiche erano intermediate dallo Stato, e di conseguenza per interi settori non aveva senso parlare di mercato e di concorrenza; e sviluppare alcune considerazioni sul ruolo che l’Autorità per la Concorrenza ed il Mercato ha avuto nella più grande trasformazione della nostra economia, vale a dire l’uscita dello Stato da gran parte delle attività finanziarie e industriali che esso gestiva.
Il processo di privatizzazione si può fare iniziare dalla legge Amato 218/1990 che, con tutti i difetti riconosciuti per primo dal suo autore, consentì pur tuttavia l’inizio della privatizzazione delle banche. Fu sempre Amato quando, da Presidente del Consiglio, dovette affrontare la crisi finanziaria del 1992, ad emanare il Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, che trasformava Iri, Eni, Ina, Enel in S.p.A. attribuendone le azioni al Tesoro, a determinare l’uscita di scena in blocco di tutti i consigli di amministrazione di origine partitica, a predisporre il famoso piano di privatizzazioni. Quel piano consentì di procedere alla vendita delle Banche di interesse nazionale, di Ina e Pignone, e di giungere infine al grande ciclo di privatizzazioni della legislatura dell’Ulivo, dal 1996 al 2001. E sintomatico che proprio Giuliano Amato fosse nominato nel 1994 dal Governo Berlusconi Presidente dell’Antitrust dove rimase fino al 1997. In un Paese nella cui Costituzione l’iniziativa economica privata è libera sì, ma subordinata ad un concetto di utilità sociale potenzialmente dilatabile a piacere, in cui non viene neppure nominata l’impresa, fu merito dell’Antitrust e in particolare di chi in quegli anni ne fu Presidente fare accettare l’idea che perché ci sia concorrenza è necessario per prima cosa abolire i monopoli di Stato, e creare consenso pubblico per la fine dello Stato imprenditore e banchiere. Fu quello il momento in cui, con l’ottimismo dei neofiti, pensammo che anche in Italia potesse diventare un’ovvia verità il detto di Lord Lawson the business of government is not the government of business.
Nel 1994 iniziò il suo iter parlamentare il processo parallelo delle leggi istitutive delle Autorità di regolazione indipendenti: infatti la legge 30 luglio 1994, n. 474 sulle privatizzazioni richiedeva che esse fossero istituite prima della dismissione delle aziende di servizio pubblico, Enel, Eni, Stet. La discussione, su un testo che Filippo Cavazzuti aveva già presentato nella precedente legislatura, iniziò in Commissione Industria del Senato. Politicamente la situazione era, per usare un eufemismo, complessa: al Governo c’era il Polo della Libertà, ma An si opponeva alla creazione dell’Autorità per bloccare le privatizzazioni; in commissione, grazie ad uno stratagemma che avevo contribuito a mettere in atto, i progressisti erano riusciti a nominare il presidente, ma questi era di Rifondazione Comunista, e anche negli altri gruppi parlamentari dei Progressisti serpeggiavano idee che un Lord Lawson non avrebbe condiviso. Inoltre la discussione si svolse con due diversi Governi. Per il Presidente della Commissione, Umberto Carpi, di Rifondazione, opporsi a Berlusconi era una ragione in più per opporsi alla legge; invece con Dini al governo, si risvegliò il suo spirito di “amendoliano di destra”, come amava definirsi. Ci furono intese anche trasversali pro-privatizzazioni, molte su emendamenti presentati da me. Ma i dettagli qui rievocati bene illustrano le difficoltà politiche, che le privatizzazioni incontrarono anche in quella che, a posteriori, ricordiamo come la stagione d’oro.
Era acuta la sensazione dei rischi che quella stagione potesse chiudersi presto. Volevamo fare in fretta: e, per trop de zèle, si rischiò pure il peggio. Come quando in Senato passò un emendamento che avrebbe praticamente tolto ogni potere all’Antitrust: intervenne Amato, minacciò le dimissioni, e si rimediò nel passaggio alla Camera. Andò peggio per un’insulsa norma che riguardava il sistema bancario: per eliminarla, si dovette contrabbandare un comma oscuro in una finanziaria. Non ci si fi, lava della saldezza dei propositi dei Governi: si temeva che i Ministeri, per mantenere i loro poteri, finissero per colludere con le aziende di Stato o per cedere alla pressione dei loro poderosi interessi, come accadde in particolare nel caso Stet-Telecom. Per questo si cercò di “forzare” il testo del disegno di legge, nel senso di estendere i poteri delle autorità oltre quelli di regolazione dei prezzi amministrati e di protezione dei diritti dei consumatori, e di intendere l’impegno a creare un mercato concorrenziale come potere di determinare anche la struttura del mercato, e gli assetti proprietari atti a garantirlo. Nel presupposto che lo Stato, per il solo fatto di operare in un settore, gode dí una posizione dominante che scoraggia il potenziale nuovo entrante. Ma per l’Europa, ai fini della concorrenza, non rileva che la proprietà sia pubblica o privata: sanzionabili sono solo i casi in cui le aziende ricevano aiuti di Stato. Fu proprio per questa ragione che, con l’accordo Andreatta-Van Miert del 1993, venne imposto all’Italia di non prestare più garanzia illimitata di Stato sui debiti delle controllate. Sempre per accelerare il processo di privatizzazioni, si pensò di inserire nella legge istitutiva delle Autorità una clausola di dissolvenza, che funzionasse come incentivo o come deterrente per completare il proprio lavoro entro un dato limite di tempo: completata la transizione ad un sistema interamente di mercato, in cui i prezzi sono dettati dalla concorrenza e non ci sono più prezzi amministrati, non ci dovrebbe più essere bisogno di un’autorità di regolazione. Un progetto illuministico che oggi può far sorridere, che di fatto non venne mai tradotto in una concreta proposta.
Fu una questione politica a vanificare il proposito di istituire, con quella legge, le autorità di regolazione di tutti i settori in cui erano richieste, in particolare anche per la telefonia. Ad op porsi fu una larga parte del centrosinistra, che vi vedeva la possibilità di cogliere un obbiettivo politico assai più rilevante, ridimensionare il potere televisivo di Berlusconi, e quindi realizzare quello che allora si chiamava “antitrust televisivo”, e imporre per questa via una soluzione pragmatica del problema del conflitto di interessi. Gli Usa avevano creato da poco una autorità per le comunicazioni: si seguisse dunque quell’esempio anche da noi, dando vita ad un’Autorità non delle Telecomunicazioni, ma delle Comunicazioni. Che, a differenza dell’Italia, negli Usa operassero da sempre operatori televisivi privati in concorrenza tra loro, che colà il settore della telefonia fosse stato liberalizzato da dieci anni con il break-up della AT&T, sembrò irrilevante. Oltretutto alla questione doveva essere interessata anche la Commissione dei Lavori Pubblici, istituzionalmente competente anche per le comunicazioni: scattò l’automatismo del not invented here contro uno schema predisposto da un’altra Commissione. Prima di dirimere la questione, cadde il Governo e si andò a votare. Così la privatizzazione di Telecom fu ritardata di alcuni anni, e la politica entrò di diritto e in pieno anche in un settore, quale quello della telefonia, da cui poteva benissimo restare un po’ più lontana. Mentre l’Autorità dell’energia elettrica era costituita da soli tre membri indicati dal Governo e approvati dalle commissioni industria a maggioranza assoluta, quando si giunse ad approvare l’Autorità delle Comunicazioni, la sí volle di otto componenti nominati dal Parlamento con voto di lista, un vero parlamentino in cui tutte le principali forze politiche potevano essere rappresentate. Le polemiche di cui è disseminata la storia della televisione privata in Italia fin dal suo primo sorgere e che resistono vigorosissimamente ancora oggi, sono lì a dimostrare che le categorie antitrust — mercati di riferimento, posizione dominante — sono strumenti per ammantare di razionalità, equità, diritti del consumatore, fair play, modello culturale europeo, una battaglia tutta politica: tanto politica che per essa caddero perfino dei Governi. Nella lunga battaglia ingaggiata dal centrosinistra contro le televisioni private, una vera guerra dei trent’anni, dall’oscuramento decretato dai pretori di Roma, Torino e Pescara nel 1984, alle leggi Mammì, Maccanico, Gasparri, alle svariate sentenze della Corte Costituzionale, il mantra dell’antitrust venne tirato in ballo innumerevoli volte, da solo e, dopo l’entrata in politica di Berlusconi, variamente mescolato e confuso con quello di conflitto di interessi. Fino al disegno di legge Gentiloni, che di questo processo rappresene .1 i l vertice supremo, là dove fissa un limite quantitativo alla raccolta pubblicitaria che un singolo gruppo televisivo può raccogliere. L’aver fissato questo limite al 45% — valore i cui fondali lei i ti razionali sono stati resi espliciti dal sorriso con cui il Pre..1, lente Prodi accompagnò il suo commento: “quarantacinque i sembra fin tanto” — comporterebbe per il concorrente dell’a: fenda pubblica di dover ridurre il proprio fatturato di circa un quarto. Nella discussione che si è sviluppata sul testo del progetto, a giustificazione di quel limite sono stati invocati proprio recedenti di sentenze antitrust che hanno comportato dismissioni forzate di aziende o di rami d’azienda. Ai fini di quanto discusso in questo libro, poco conta che si trattasse di paragoni mal posti, dato che qui la posizione di Mediaset era stata raggiunta non grazie a fusioni o concentrazioni, ma per crescita endogena successiva, senza che mai fossero violate leggi dello Stato: è invece un esempio da manuale di come la retorica antitrust sia diventata un paradigma, abbia acquisito lo status di un principio superiore, di un assioma indiscutibile, spendibile bene aldilà di una “benigna” regolazione dei mercati, anche quando viene usato a supporto di operazioni politiche, anzi di vendetta politica. E come se il principio etico dell’eguaglianza venisse usato in senso traslato ed esteso al mondo delle imprese: la prassi antitrust riceve così la legittimità “morale” dei provvedimenti atti a garantire quell’imperativo. Così si finisce per richiedere che anche nel mercato concorrenziale valga il principio del level playing field, inteso come il corrispettivo del principio di eguaglianza delle posizioni di partenza. L’aspirazione ad un mondo in cui non ci sia dominio di alcuni uomini su altri diventa presunzione di abuso da parte di ogni impresa in posizione dominante rispetto ad altre. In conclusione, la legge istitutiva delle Autorità, approvata sotto il Governo Dini, fu monca della parte relativa alla telefonia.
La riforma della normativa antitrust delle manche, problema complesso in sé, da noi fu un processo particolarmente lungo e tormentato. Da anni circolavano progetti di controllo per funzioni, che lasciasse alla Banca d’Italia il controllo di stabilità attraverso la Vigilanza, desse all’Antitrust il controllo di concorrenza in tema di fusioni e concentrazioni, e alla Consob quello di trasparenza. Nel Governatore si assommavano, rinforzandosi a vicenda, il potere di controllo sull’operatività, attraverso la vigilanza, e quello sulla strategia, attraverso l’antitrust, poteri resi insindacabili dallo statuto e dallo status della Banca, ed imperituri dal mandato a vita del Governatore. Il modo in cui la Banca d’Italia durante il Governatorato di Antonio Fazio fece uso dei poteri antitrust, è una dimostrazione esemplare di imposizione al mercato di un “piano regolatore” dell’autorità, della teoria su cui si fonda, e delle minuziose regole a cui gli operatori devono sottostare (il così detto “confessionale”). E questo in modo del tutto legittimo, anzi rafforzato da apposite delibere CICR. Ci vollero gli scandali Cirio, Parmalat e bond argentini, e più ancora le vicende legate alle scalate Bnl e Antonveneta, perché il Parlamento varasse la legge sul risparmio che ridimensiona il potere antitrust di Banca d’Italia e perché ad Antonio Fazio succedesse Mario Draghi.
La politica oppone ovunque, in misura maggiore o minore, resistenze a rinunciare a disegnare í mercati secondo la propria visione. In Italia la resistenza era diffusa da destra a sinistra: ad esempio, il senatore di AN Armani, già consigliere IRI, tentò di bloccare la costituzione delle autorità di settore, sostenendo che i loro poteri sono in contrasto con il diritto amministrativo; il processo di vendita sia dei diritti di proprietà sia degli asset degli ex monopoli non fu mai delegato alle Autorità, Antitrust o di settore, ma si richiese che per ciascuno ci fosse uno specifico atto di Governo sanzionato dal Parlamento; la possibilità da parte delle Fondazioni di concorrere al controllo delle banche venne mantenuto grazie a intese trasversali; l’Europa, come già ricordato, non discrimina in base alla proprietà, pubblica o privata, non considera che il controllo pubblico di un’azienda agisca di per sé come un deterrente e crei una barriera all’entrata, ma giudica solo gli aiuti di Stato come distorsivi della concorrenza. Ci sono casi in cui l’intervento della politica è così pervasivo, e lascia tali incrostazioni, che neppure i criteri liberisti consentono di orientarsi. Prendiamo il caso del gas: politica l’assegnazione all’Eni, quando era interamente posseduta dallo Stato, addirittura secretandone il prezzo di acquisto; politica la decisione se consentire l’allacciamento con il gasdotto dal Caucaso o lasciare che continui a venire dalla Russia; politiche le resistenze ai rigassificatori; come giudicare, dal punto di vista della creazione di un mercato concorrenziale, la richiesta dell’Antitrust di vendere Snam Rete Gas, quando già si sa che, se mai a tanto si arrivasse, essa rimarrebbe di certo sotto il controllo pubblico, tramite la Cassa Depositi e Prestiti? Come un intervento utile solo a distogliere gli occhi dal vero problema, o come l’unico benemerito granello di sabbia messo in un ingranaggio?
La mia opinione è che, in mezzo a tante resistenze, a spingere in direzione di privatizzazioni e liberalizzazioni l’Antitrust italiana ebbe un ruolo di primo piano: per anni l’autorità, segnatamente sotto la Presidenza Amato, si assunse il ruolo di diffondere narrative sull’aumento di benessere sociale associato all’uscita dello stato dalla gestione di imprese economiche, usò la lotta al monopolio come “retorica” per promuovere la privatizzazione. Anche l’Antitrust europeo contribuì in modo determinante prescrivendo il diritto di accesso non discriminante e a condizioni di mercato alle essential facility: in tal modo veniva considerevolmente abbassata la principale barriera all’entrata, la posizione dominante delle imprese di Stato formatesi non per competizione sul mercato, ma per riserva di legge. L’interpretazione che la Corte di Giustizia diede della libertà di circolazione di beni e di capitali previsti dal Trattato di Roma, consentì a Bruxelles di raccogliere un successo pieno nel settore della telefonia mobile, e uno più faticoso nella telefonia fissa. Indipendentemente da come lo si giudichi nel suo complesso, l’intervento del legislatore è stato necessario per smontare i monopoli creati da un precedente legislatore. Quando il problema è (ri)creare un mercato dove il mercato non c’era, allora non ci sono principi generali a cui ispirarsi, e ci si deve accontentare di un empirismo comunque esposto alle critiche. Da una parte, le forze di mercato su cui si può contare per l’eliminazione delle barriere all’ingresso possono essere deboli e il processo essere troppo lungo; dall’altra più si vuole accelerare e più pesanti e intrusivi sono gli interventi. Bisogna scoprire una procedura per creare il mercato. Ed è pur vero che quando si osserva quanto numerosi e minuziosi e prescrittivi siano gli interventi delle autorità in termini di tariffe, di borse elettriche, di incentivi, di prescrizioni, di casse conguaglio, vien da chiedersi se il libero mercato concorrenziale non sia in realtà un’astrazione o un miraggio. Quando poi dai beni materiali si passa ai beni via via più immateriali, le cose diventano ancora più complicate. È questo il caso di uno dei più immateriali dei beni, la sicurezza, la protezione contro il rischio: cioè proprio quello di cui si occupa questo libro.
Lo spunto è costituito da un fatto che riguarda la RC auto, cioè da uno dei tanti, e certo non dei più sofisticati prodotti dell’industria assicurativa: ma la discussione di carattere generale che viene sviluppata a partire da questo caso è di grande interesse a causa dell’ampiezza dello spazio che assumono le assicurazioni private nella vita delle persone: perché l’industria assicurativa assume sempre più un ruolo di surrogato dello Stato nel fornire ai cittadini le fondamentali prestazioni del welfare, malattie, invalidità, vecchiaia. Questo è già oggi il problema centrale dei governi dei Paesi ad alto reddito, lo diventerà sempre di più: infatti, con l’aumento delle prestazioni dovuto all’accresciuta durata di vita e ai progressi medici, e con la riduzione delle entrate dovuta alla demografia, si è rotto l’equilibrio che aveva funzionato ai tempi di Bísmarck prima e di Beveridge poi. Non si tratta solo di un problema di efficienza, eliminare gli sprechi connaturati alle organizzazioni pubbliche, o di moralità, evitare il pericolo sempre immanente a causa del conflitto di interessi tra regolatore e regolato. Si tratta di uscire dalla logica del one size fits all, quella per cui il diritto universale dovrebbe escludere il diritto individuale di scegliere, entro certi limiti, tipo e entità di copertura desiderata. Solo lo strumento assicurativo sembra in grado di potere fornire la soluzione. È quindi di preminente interesse generale che il sistema assicurativo sia all’altezza di una sfida che si gioca su due piani, quello oggettivo e quello soggettivo. Oggettivo, per la dimensione economica e la complessità organizzativa che essa comporta. Ma soprattutto soggettivo, per le aspettative degli assicurati, e dunque anche per le inevitabili delusioni che si scaricheranno sul sistema assicurativo. Componente soggettiva aggravata dal fatto che in Italia, mentre la tolleranza verso le ingiustizie perpetrate dal pubblico è il lascito di un’atavica costrizione a piegare la schiena di fronte alle vessazioni del signore, assai più recente è la fiducia nel mercato. Recente, e, va riconosciuto, troppe volte delusa. La coscienza per questi problemi, la preoccupazione per un buon funzionamento di questo mercato, con i suoi incentivi economici e reputazionali, con le sue regole e í suoi regolatori, è quella che percorre i saggi di questo libro.
Se si dilatano ruolo e ambito operativo delle assicurazioni, parallelamente si dilata anche il campo dei rischi assicurabili: è il concetto stesso di rischio a subire un’evoluzione. Rischi non sono solo gli eventi negativi che possono colpire uomini e aziende, gli incidenti, gli incendi, i furti, le malattie e la morte, il campo tradizionale delle imprese assicurative. Rischi fanno parte anche della vita normale di un’impresa, della sua attività propria: quando si parla di rischio d’impresa, si vuol dire che quella dell’imprenditore è un’attività di cui il rischio è componente intrinseca. L’imprenditore usa la sua competenza per ridurre il rischio di un’attività in cui ha particolare attitudine o particolari conoscenze: se sa fare bene il pane, sa controllare il rischio che lieviti male o che si bruci nel forno; se sa disegnare un’automobile, prende su di sé il rischio che non incontri il consenso del pubblico. Ma esistono numerosissime componenti dell’attività di imprenditore in cui egli non ha specifica competenza o che non dipendono dalla sua abilità. Il panificatore potrebbe non essere competente nel prevedere il costo futuro della farina, o gli andamenti climatici che ne influenzano il prezzo; chi produce mattonelle potrebbe non essere esperto nel prevedere se í dollari in cui ha venduto il suo prodotto varranno di più o di meno. Nel rischio c’è anche una componente soggettiva, relativa alla abilità o alla dotazione di competenze e conoscenze. L’andamento del cambio è un rischio per chi esporta, ma è il mestiere di chi opera sui cambi. Il rischio diventa un prodotto come un altro, che ha un prezzo e che a sua volta può essere scambiato. L’industria finanziaria ha inventato prodotti sempre più sofisticati di copertura da rischi. Si vende e si compera il rischio di non incassare un credito, quello che il debitore non onori í suoi impegni. Esistono prodotti finanziari che limitano íl rischio inerente ad altri prodotti finanziari, cioè che limitano il rischio di comperare un rischio. In questo modo l’industria finanziaria consente un aumento di efficienza da specializzazione, dato che ciascuno fa quello di cui è competente, crea opportunità di entrare nel mercato a chi altrimenti non le avrebbe, fornisce liquidità al sistema: è un potente strumento di crescita. Solo per riferirci a un esempio che riempie le cronache finanziarie: i mutui subprime, forniti senza collateral, a persone che scontano avanzamenti di carriera e quindi di entrate, ha offerto a migliaia di persone la possibilità di avere una casa che altrimenti non avrebbero potuto avere fin molto oltre nella loro vita, e forse mai.
La grave crisi finanziaria che ha investito le Borse di tutto il mondo ha scatenato la caccia al colpevole. Sul banco degli accusati sono stati posti in successione chi ha venduto mutui subprime alle famiglie, le banche che li hanno ceduti a loro veicoli fuori bilancio, le società di rating che li hanno valutati, i trader che hanno speculato, e, immancabilmente, gli hedge fund. Ci si è accorti improvvisamente di quanto sia difficile valutare l’intrinseca rischiosità di prodotti sempre più complessi. Nell’incertezza sul reale valore dei beni prestati a garanzia e sulla solvibilità delle controparti, si è bloccato il normale circuito di finanziamenti interbancari, e, anche dopo che le banche centrali hanno fornito abbondante liquidità, è diminuita la quantità di danaro realmente scambiata ed è aumentato il costo per il finanziamento del rischio.
Finisce sotto accusa anche il modo con il quale le banche centrali hanno cercato di arginare la crisi di liquidità: perché anziché punire il moral hazard, così lo incoraggiano, e risolvendo un problema ne creano altri, in una catena senza fine. E questo riguarda in primo luogo la Fed per come ha reagito per scongiurare che eventi eccezionali come 1’11 settembre, ma anche lo scoppio di normali bolle speculative, evolvessero in vere e proprie crisi. Nell’eccitazione del momento qualcuno ha paragonato questa alla crisi del 1929; ma allora a trasformare un crollo in Borsa in una crisi decennale fu il protezionismo del presidente Hoover; un monetarismo ante litteram e distorto della Fed che guardava alla quantità di moneta in termini reali anziché nominali, e riduceva la moneta man mano che la recessione causava riduzioni del livello dei prezzi; e financo il New Deal di F.D. Roosevelt per le regolazioni e i regolatori che introdusse. Ironia (ella sorte, oggi a capo della Fed si trova proprio Ben Bernanke, che di quegli avvenimenti è uno dei più illustri studiosi. Forse anche perché, a differenza di quanto era avvenuto nei casi tipo Enron in Usa e Parmalat da noi, non si individuano colpevoli sanzionabili penalmente a cui addossare la colpa della crisi, e ton solo di singoli episodi, si moltiplicano le richieste di creare autorità di vigilanza e regolazione della finanza mondiale, in grado di sottoporre l’intero sistema finanziario a controlli severi. Anche George Soros, diventato a suo tempo famoso per l’attacco alla sterlina e alla lira, sostiene che ora che la finanza è diventata globale ci vogliono controllori globali. Ma le responsabilità di avere creato derivati contenenti i subprime, e di averli collocati in veicoli fuori bilancio, è delle banche: di soggetti quindi già sottoposti ad autorità di controllo esistenti e pienamente dotate dei poteri per conoscere e per sanzionare. Oltretutto nel presupposto che questa istituenda autorità superiore possa avere le conoscenze per regolare i flussi finanziari mondiali e il potere per fare rispettare le proprie indicazioni. Un’autorità che avrebbe in comune con l’antitrust lo stesso disegno costruttivista, la stessa ambizione di modellare l’attività regolata secondo le idee del regolatore. Con il che ritorniamo al tema di fondo di questo libro.
Alla fine del quale, in un notevole saggio, Alan Greenspan attacca in radice i fondamenti teorici dell’attività antitrust, ne mostra l’intima contradditorietà, ne nega l’utilità pratica. Proprio il futuro Presidente della Fed, all’epoca giovane economista, identificava nell’Antitrust una «concentrazione di potere arbitrario» equivalente a quella, tanto temuta dagli americani, “nelle mani dei politici”. Paradossalmente, è a questo acceso criico, sul piano teorico, dell’intervento nei mercati, che vengono in prima persona rimproverate le conseguenze nefaste di un intervento volto a sostenere i corsi azionari. Fatto singolare: nei riguardi da un lato dell’antitrust dall’altro della politica monetaria che ha contributo a causare una delle più gravi crisi finanzia rie degli ultimi decenni, la stessa persona, Alan Greenspan, è in un caso accusatore e nell’altro imputato in un processo in cui si
mette in dubbio l’utilità e fin la legittimità di ogni intervento regolatorio e sanzionatorio. Ancora una volta, anche chi — come il sottoscritto — teme le conseguenze inintenzionali degli interventi regolatori, e crede nell’inventiva imprenditoriale e nella tecnologia per limitare e sovvertire i rapporti di potere nel mercato, non è però disposto a negare cittadinanza ad interventi volti a ridurre l’ampiezza delle oscillazioni nei cicli economici, e quindi a considerare legittimi gli interventi delle Banche centrali per variare i tassi a breve, o a regolare la massa monetaria; e pur vedendo i miseri risultati degli interventi delle istituzioni internazionali, a volte addirittura contrari agli scopi che si propongono, ha difficoltà a pensare che i grandi flussi finanziari non debbano in alcun modo essere concordemente indirizzati.
In un lavoro che analizza fatti precisi — specifiche sentenze e interventi governativi in vari rami assicurativi, il più generale tema dello scambio di informazioni e del ruolo dell’assicurazione e discute i presupposti su cui si basa l’azione antitrust su mercati e imprese, sarebbe fuori luogo andare oltre il semplice accenno a interrogativi di portata enormemente maggiore, con i quali può perfino apparire paradossale istituire paralleli. Se lo si è fatto, è per ricordare lo scarto che sempre esiste tra limpido disegno del modello e ruvida intrattabilità dei fenomeni, e il ruolo che la politica ha nel muovere dal modello per agire sul fenomeno, nel selezionare le regole e piegarle alle eccezioni. La storia dei successi e insuccessi delle privatizzazioni in Italia sono da questo punto di vista un manuale: ed è per questo che mi sono dilungato a raccontarne dettagli. Ma già il giudizio su che cosa debba definirsi successo e che cosa insuccesso dipende da una scelta — ma forse dovremmo dire da un pregiudizio — politico. D’altronde, che ne è oggi del Washington consensus, del “pensiero unico” che ancora pochi anni fa sembrava inossidabile? Se lo si dice, non è per indurre ad arrendersi allo scetticismo radicale, ma al contrario per indicare il potere delle idee e delle “retoriche”, e l’appassionante professione intellettuale del diffonderle.
ARTICOLI CORRELATI
Convegno: L’Antitrust e il libero mercato
di Franco Debenedetti – 02 luglio 2008
Quando l’Antitrust fa autogol
di Franco Debenedetti – Il Sole 24 Ore, 28 giugno 2008







maggio 30, 2008